La televisione secondo Umberto Eco, lezioni sempre attuali
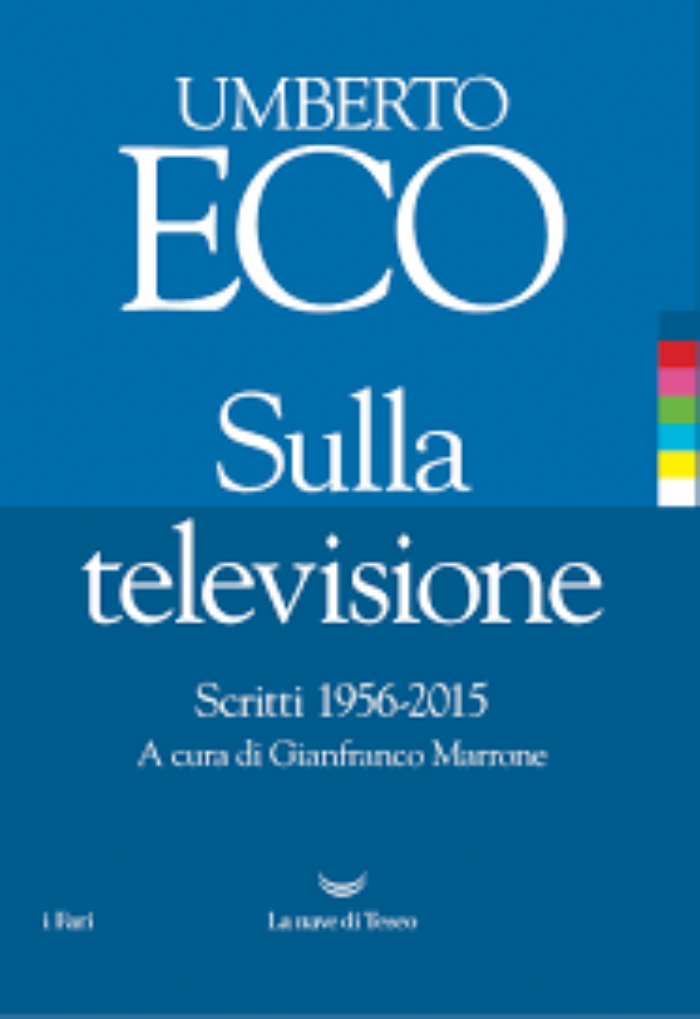
UMBERTO ECO, 'SULLA TELEVISIONE'
(A cura di Gianfranco Marrone)
(NAVE DI TESEO, PP. 553, 22 EURO).
Campanile sera, La Figlia del capitano, il Festival di Sanremo, Specchio segreto, Tom e Jerry, Tribuna Politica, Canzonissima, I tre moschettieri, All in the family, Twin Peaks, il telegiornale, Portobello, La Corrida, Il Tenente Colombo, Beautiful, l’Ispettore Derrick, Un giorno in pretura, il Grande Fratello: come dire, Mike Bongiorno non era l’unico bersaglio della «spietata critica» che, per un sessantennio, Umberto Eco ha condotto alla televisione, italiana e straniera. L’ultimo libro del celebre studioso, scomparso quasi due anni fa lasciando un’eredità intellettuale di delicata e complessa gestione, lo dimostra ampiamente.
Il semiologo e saggista Gianfranco Marrone, che a quest’eredità «tiene moltissimo», come sostiene, ha difatti raccolto una gran quantità di scritti di Eco dedicati al piccolo schermo: «Sulla televisione» è il titolo, edito dalla Nave di Teseo (pp. 533, euro 22), da oggi in libreria. «Questi scritti coprono un arco di tempo che va dal 1956, anno in cui la Rai vara le sue prime trasmissioni, al 2015, - afferma Marrone - periodo in cui il mezzo televisivo perde la sua supremazia fra i media di massa, cedendo il posto alla rete. Un tale arco di tempo coincide con l’intera carriera di Eco come professore e scrittore, pensatore e opinionista, linguista, uomo d’editoria e, al suo inizio, funzionario del servizio pubblico della Radio Televisione Italiana». Sono testi di varia natura, molti dei quali praticamente inediti: saggi scientifici, analisi di trasmissioni, interventi a caldo, report di ricerche empiriche, risposte a questionari, articoli giornalistici, scritti di fiction. «Ne viene fuori, tristemente, - afferma il semiologo - che le strade seguite dalla televisione sono state radicalmente opposte a quelle che Eco s'attendeva e pretendeva, andava suggerendo e auspicando, con toni diversi, avversari diversi, ma lo stesso spirito di fondo: uno spirito politico - quello di chi ha innanzitutto a cuore una 'res pubblicà che la televisione avrebbe potuto contribuire a formare e a gestire, preferendo però, fatalmente, fare il gesto dello struzzo che, cacciando la testa sotto la sabbia, mostra il sedere a un telespettatore carico di curiosità e di perplessità. Sono parole sue».
Gianfranco Marrone è professore ordinario di Semiotica
nell’Università di Palermo. Insegna Semiotica dell’alimentazione
e del gusto nell’Università delle scienze gastronomiche di
Pollenzo. Ha introdotto e tradotto in lingua italiana diverse
opere di Roland Barthes e Algirdas J. Greimas. Tra i suoi
scritti: Il sistema di Barthes (1994), Estetica del
telegiornale (1998), C'era una volta il telefonino (1999), Corpi
sociali (2001), Montalbano (2003), La Cura Ludovico (2005), Il
discorso di marca (2007), L’invenzione del testo (2010), Addio
alla Natura (2011), Introduzione alla semiotica del testo
(2011), Ccà ddà ddocu (2011), Stupidità (2012), Figure di città
(2013), Gastromania (2014), The Invention of the Text (2014),
Dilettante per professione (2015), Semiotica del gusto (2016),
Principes de la sémiotique du texte» 2016; Roland Barthes:
parole chiave (2016); Prima lezione di semiotica (2018), Storia
di Montalbano (2018).
Ultimi articoli
 Francesco, il papa che pensava agli ultimi
Francesco, il papa che pensava agli ultimi  Lo ingiuriavano, ora lo piangono
Lo ingiuriavano, ora lo piangono  Pippo Oddo, tante vite
Pippo Oddo, tante vite
e un sogno incompiuto L’emozione dei ragazzi
L’emozione dei ragazzi
per La Torre e Di Salvo i giovani promuovono
i giovani promuovono
il ricordo di Pio La Torre
e Rosario Di Salvo Gerges Simenon,
Gerges Simenon,
la vita in tanti fotogrammi
di bellezza Giustizia, dove porta la riforma di Nordio
Giustizia, dove porta la riforma di Nordio  Solo lo stupro nero diventa caso nazionale
Solo lo stupro nero diventa caso nazionale  Meli, l'intellettuale
Meli, l'intellettuale
distante dalle accademie Mercati azionari, la Grande Rapina
Mercati azionari, la Grande Rapina