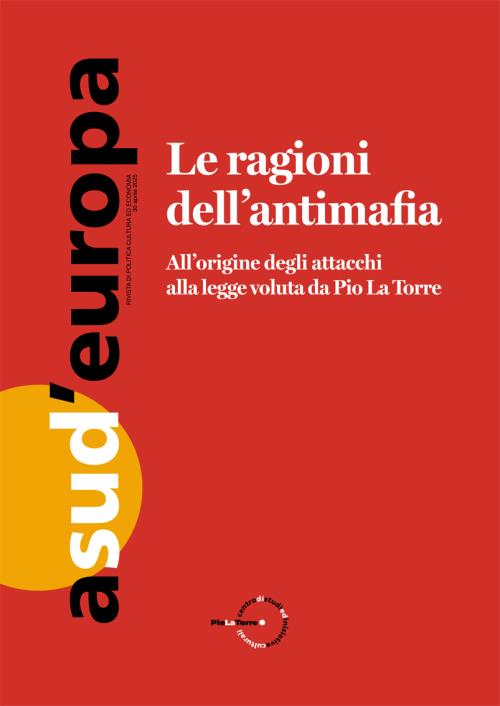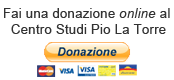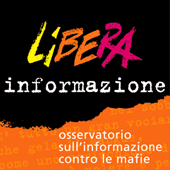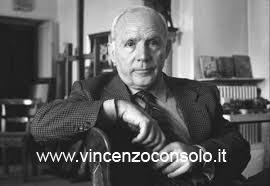Economia e criminalità

Atti del Convegno
"L'economia mafiosa dai confini regionali al mercato mondiale"
N.B. La trascrizione degli interventi degli oratori ufficiali è stata effettuata a cura del Centro di Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre". Si avverte che i testi non sono stati corretti dai relatori.
GIANNI PARISI: "Prima di dare la parola a Calabrò, che coordinerà il dibattito, volevo dire brevemente il perché di un dibattito su questo tema. Credo innanzitutto che il fatto che il nostro Centro si intitoli ad una figura come quella del Pio La Torre già spiega il fatto che nella serie di iniziative di questa nuova fase dell’attività del Centro "Pio La Torre", questo tema non potesse mancare. Teniamo conto che ci troviamo a quindici anni dall’approvazione della legge "La Torre" e che quindi, probabilmente, già è venuto il momento di un bilancio di questa legge, dei suoi risultati e di come è stata applicata specialmente sul terreno dei sequestri e delle confische, se è stata applicata fino in fondo, se ha bisogno di modifiche. Su questi particolari ci saremmo aspettati un parere dal Presidente alla Commissione Parlamentare Antimafia on. Del Turco anche se qui abbiamo un componente di questa Commissione che è il Senatore Figurelli. D’altra parte questo tema ci è stato dettato anche dal fatto che alcune caratteristiche, diciamo cosi classiche, tradizionali della mafia in rapporto all’economia si sono presentate negli ultimi anni con forti accentuazioni e forti novità. In particolare recentissime acquisizioni, anche attraverso processi, attraverso deposizioni anche recenti, mi riferisco per esempio all’ultima quella dell’imprenditore Sebastiano D’Agostino uno dei più importanti imprenditori Palermitani e Siciliani, comprendiamo come la pressione forte della mafia sull’economia, l’estensione e l’intensità della presenza dei capitali mafiosi nell’economia si sia fortemente accentuata, radicata. Si aprono nuovi squarci sulla responsabilità delle radici della mafia nell’economia, dell’intreccio sempre più grande fra capitale di origine illegale con attività legali. Contemporaneamente è degli ultimi anni anche la sensazione di un forte estendersi di questa presenza oltre i confini tradizionali delle regioni classiche come la Sicilia, la Campania, la Calabria, estensione di questa presenza proprio dal punto di vista economico e finanziario a livello nazionale, in altre regioni italiane; così come è venuto avanti negli ultimi anni lo svilupparsi in campo internazionale non soltanto dei tradizionali rapporti Sicilia - Stati Uniti o Italia - Stati Uniti, ma il venire avanti di altre mafie, di altre criminalità organizzate economiche. Dopo i cartelli Sud Americani e presenze mafiose medio orientali, entrate in campo negli ultimi anni le mafie Est europee, in particolare la mafia Russa che, con la sua particolare virulenza primordiale e con alle spalle ampia possibilità di pescare risorse economiche e finanziarie in una fase transitoria turbolenta e confusa come quella dell’ex Unione Sovietica, fa temere forti reazioni, perfino la possibilità che questa mafia possa attingere ad ogni tipo di armi, compresi materiali nucleari. Ciò significa che in campo internazionale queste presenze cominciano ad essere talmente ingombranti sia sul piano economico che su quello finanziario, che c’è da chiederci, anche dal punto di vista politico, del potere di questa forza, a quale punto siamo arrivati?.
Qualcuno, qualche magistrato in particolare, ha parlato dell’esistenza di una sorta di cupola mondiale; ora io non so dire se così è, se siamo a questo punto; ma ove esistesse veramente una qualche cosa del genere c’è da riflettere su quale influenza tutto ciò potrebbe avere anche sulla realtà politica internazionale. Ora per tutte queste ragioni abbiamo pensato di affrontare questo dibattito, questo tema; quindi uscendo anche dal tradizionale e diciamo dal confine dell’influenza economica della mafia in Sicilia, nei rapporti con l’economia siciliana per appunto affrontarla tenendo d’occhio tutte queste novità.
L’altro interrogativo al centro di questo dibattito è: quale è l’influenza dell’economia mafiosa nell’economia pulita?.
Certo, essa scoraggia l’impresa, le pone delle condizioni, dei fardelli, dei lacci, che scoraggiano l’impresa. Ma essa impedisce lo sviluppo economico? Il problema è solo questo o c’è un problema più complesso; quale sviluppo induce la presenza dell’economia mafiosa, quale "Tipo" di sviluppo?.
Non vi è dubbio che lo sviluppo che induce la forte presenza mafiosa, uno sviluppo senza regole, senza concorrenza, induce un carattere distorto e "sbagliato" dello sviluppo stesso. Ma ciò non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista politico - istituzionale.
E cioè uno sviluppo fondato su una non piena libertà dei cittadini e delle imprese, su un cattivo funzionamento delle istituzioni e degli apparati amministrativi.
Cioè il problema mafia, prima che un problema economico e sociale è un problema di democrazia e di politica.
La mafia può proliferare indifferentemente in zone economicamente arretrate o in zone sviluppate, ma prolifera senz’altro in zone a non piena vita democratica, a sovranità limitata.
Abbiamo chiamato per questo confronto Antonio Calabrò che è Vice Direttore di "Sole 24 Ore" al quale poi passerò la parola e che coordinerà il dibattito; il prof. Mario Centorrino economista e autore di studi anche recentissimi proprio sulla materia; Napoleone Colajanni economista e io direi anche vivace polemista politico.
Michele Figurelli senatore della Commissione Antimafia e il Dott. Sergio Lari magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura che ha operato in Sicilia a Trapani in particolare.
Ho già detto, purtroppo, dell’assenza di Del Turco e quindi direi di iniziare subito dando la parola a Calabrò".
ANTONIO CALABRO’: "Grazie a Gianni, grazie a voi della vostra presenza. Il tema avete visto è l’economia mafiosa dai confini regionali al mercato mondiale. Detta così è una questione da provocare un certo sgomento, sarebbe l’equivalente del parlare assolutamente di tutto e, probabilmente, discutere oggi di economia mafiosa in Sicilia e relazioni internazionali può dare la sensazione di un discorso già scontato e ingenerare dei meccanismi di ripulsa, di noia, di disattenzione.
Abbiamo fatto i conti per anni con l’economia mafiosa in Sicilia, guardavo oggi su RAI TRE un breve documentario sulla vita e le imprese di un giornale che è stato molto importante per questa città e per quest’isola "L’Ora", chiuso, purtroppo, nel ’92, un giornale in cui in tanti siamo cresciuti e che ha comunque segnato profondamente la vita di quest’isola. Il tema forte che aveva caratterizzato tutta la vita de "L’Ora" era stata la riflessione, non soltanto sulle degenerazioni del rapporto tra mafia e politica a Palermo e in Sicilia ma anche una costante denuncia del rischio della internazionalizzazione del potere mafioso e della pesantezza del condizionamento che l’economia mafiosa poteva giocare sull’economia normale del paese.
Dunque se questi sono temi vecchi, temi degli anni ’60, degli anni ’70, degli anni ’80 quando Giovanni Falcone da magistrato a Palermo e da dirigente di altissimo livello del Ministero di Grazia e Giustizia ammoniva sui rischi di questa degenerazione perché, quindi, parlarne adesso?. La risposta è molto facile, tenteremo di darla in modo abbastanza articolato nel corso di questo dibattito.
E la risposta può cominciare a prendere le mosse da una parola che sentiamo pronunciare ogni giorno durante i telegiornali, sui giornali ed è la Globalizzazione, cioè la crescente inte relazione tra fenomeni economici nel corso degli ultimi tempi, inte relazioni crescenti e che attraversano in modo reciprocamente dipendente le economie internazionali. Tutti quanti voi dai giornali avete saputo della crisi Coreana. Che centra la Corea con la mafia? Colajanni e Centorrino lo spiegheranno molto meglio di me, ma una parte consistente della crisi Coreana è legata ai movimenti di capitale, ai movimenti speculativi di capitale che si concentra dove ci sono situazioni economiche particolarmente squilibrate e valute possibilmente o deboli o suscettibili di forte indebolimento. La Corea presentava queste caratteristiche: una crescita economica fondata su un eccesso di debiti, forti attività imprenditoriali legate ad una eccessiva esposizione da parte di banche che erano contemporaneamente azioniste delle stesse imprese, uno squilibrio di bilancio pubblico, insomma tutto quello che dà ad un paese una crescita molto vistosa e molto rapida: questa era la crescita Coreana e però una grandissima debolezza.
Fenomeni analoghi, anche se meno devastanti, in Giappone. Che cosa si è mosso? Si sono mossi sulle valute deboli flussi enormi di capitali finanziari; i capitali sono come l’acqua che scorre, vanno là dove ci sono dei canali particolarmente disponibili ad accoglierli. Hanno puntato sulla debolezza Coreana e hanno puntato sulla debolezza delle banche Giapponesi e sulla situazione, che non sto qui a raccontare, di particolari fragilità di alcuni paesi. E ancora che c’entra la mafia? C’entra, per dirla molto schematicamente, se si considera che all’interno di questi giganteschi flussi di capitali una parte consistente fuori controllo è rappresentata da capitali di origine illegale. Quale diventa allora il tema? Come si fa ad impedire che, in un mondo caratterizzato comunque da una consistente capacità e libertà di movimento dei capitali, le risorse finanziarie di origine illecita aggravino la forza devastante legata comunque a questa grande possibilità di movimento?. Secondo tema: questi strumenti di controllo per non essere velleitari come vanno organizzati?. Come vanno coordinate le risorse dei singoli paesi per evitare che questa enorme ricchezza, che proviene da attività illegali, riesca ad avere effetti molto più pesanti del normale gioco speculativo dei capitali?. Uso "speculativo" senza nessuna accezione negativa: funzione normale del capitale ad avere la capacità di creare margine di profitto là dove le condizioni sono migliori. Perché è preoccupante il gioco dei capitali di origine illegale? Perché non paga nessuno dei prezzi che il normale capitale finanziario paga, proviene da attività illecite con larghissimi margini di utile, non è sottoposto a controlli e sanzioni fiscali, si muove con margini di utilità molto maggiori dei capitali normali. Dunque ha una forza di impatto molto maggiore di quelli normali.
Da questo punto di vista il problema della pulizia dei mercati finanziari internazionali, soprattutto aperti, è un problema che non riguarda soltanto i singoli Stati, ma riguarda le economie e gli stessi grandi mercati finanziari. Non a caso gli allarmi per la presenza illegale, per dirla più genericamente, all’interno dei mercati finanziari, gli allarmi vengono da due grandi istituzioni di controllo: la SEC, cioè l’organismo di controllo della borsa di New York e l’organismo di controllo della borsa giapponese. Tutte e due sostengono, hanno sostenuto in tempi recentissimi che c'è una crescente penetrazione di quei sistemi finanziari nei meccanismi di borsa, sia a New York che a Tokyo, da parte di capitali internazionali di origine illecita, mafia americana - mafia giapponese e che questi capitali alterano profondamente il corso dei mercati. Non a caso un allarme analogo è venuto in tempi recenti, è stato ribadito sia da parte del fondo monetario internazionale sia da parte della banca mondiale, da parte dei rappresentanti delle istituzioni finanziarie e dagli organismi di controllo sulle istituzioni finanziarie per i danni che può fare l’economia mafiosa.
Dunque economia mafiosa pensando che questi capitali, che vengono da traffici organizzati dalla mafia siciliana - americana - giapponese, camminano lungo gli stessi canali lungo cui camminano altri tipi di capitali sempre di origine illegale che poi vengono inseriti all’interno dei circuiti finanziari come gli altri ma presentandosi, appunto, meno costosi e meno vincolati, con capacità di impatto crescente. Questo è il quadro per cui vale la pena ragionare stasera tentando di capire quali sono i meccanismi di controllo, perché è vero che questi meccanismi vanno posti a salvaguardia degli stessi mercati finanziari internazionali.
Un altro allarme, particolarmente significativo, viene da un signore che si chiama George Soros che probabilmente molti di voi sanno chi è. Soros è uno dei più bravi, brillanti, spregiudicati e intraprendenti speculatori finanziari internazionali, cioè un signore che fa un sacco di soldi ogni giorno muovendo enormi quantità di soldi da un posto all’altro, da una valuta all’altra valuta, da un prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare e così via di questo passo. Ebbene Soros, grande speculatore internazionale, è tra i più preoccupati che la libertà di movimento di capitali su quei mercati possa ostacolare il normale gioco dei finanzieri, spregiudicati quanto volete, ma non di origine illegale. Si può fare qui un’altra domanda ed è la seguente: il controllo sui mercati finanziari è possibile senza ledere la libertà dei mercati finanziari stessi?. Le risposte sono complicate, i nostri economisti interverranno sicuramente su questo e probabilmente, sentivo dire da Colajanni adesso, se questo controllo non è possibile ci sono misure internazionali o all’interno dei singoli Stati per evitare all’origine la formazione di capitali che poi immessi sui circuiti finanziari liberi provocano gli effetti di cui abbiamo parlato.
E per scendere alle cose di casa nostra c’è un riferimento particolare che ci riguarda, visto che qui a Palermo parliamo, ed è il riferimento alle ipotesi ed alle possibilità di sviluppo delle economie dei paesi deboli, nesso che sembra lontano ma che invece ha una sua pertinenza proprio in Sicilia. Sempre guardando l’immagine sul quotidiano "L’Ora" c’è un titolo molto bello fatto dal vecchio direttore de "L’Ora" che si chiama Vittorio Nisicò per la prima inchiesta sulla mafia de "L’Ora", credo nel ’57 o nel ’58. Il titolo diceva "La mafia dà pane e morte". Nella sua semplicità voleva dire però una cosa fondamentale su cui negli anni in tanti hanno ragionato, per esempio Mario Centorrino, che ha scritto delle cose molto lucide, cioè la mafia è contemporaneamente un meccanismo di arretratezza economica ed un meccanismo di sviluppo economico distorto. Come si fa a rompere questo intreccio tra la possibilità di dare occupazione e sviluppo, illusorio e distorto, e la possibilità di sottrarre risorse allo sviluppo?. O se vogliamo dirla in modo più esplicito, come si fa a costruire un’economia nel Mezzogiorno d’Italia ed in Sicilia, in cui non succeda non soltanto che gli imprenditori Siciliani stabiliscano rapporti obliqui verso l’economia mafiosa ma anche le grandi imprese nazionali, Gardini e Ferruzzi, per dire un esempio venuto alla ribalta nelle cronache negli ultimi periodi, utilizzino il rapporto mafioso per intervenire sui mercati finanziari - nazionali e internazionali stravolgendoli. Perché la presenza di Ferruzzi e i suoi rapporti con la mafia, a rileggere oggi le carte di quei processi, di quegli accordi, non è stato soltanto un elemento di forte perturbazione del mercato delle opere pubbliche in Sicilia ma è stato, probabilmente le indagini ce lo diranno, un elemento di profonda alterazione degli stessi mercati finanziari nazionali. Per esempio Ferruzzi era quotata in borsa, Calcestruzzi era quotata in borsa, parecchie imprese del gruppo Gardini erano quotate in borsa a Milano. Ma probabilmente anche dei mercati finanziari internazionali, se è vero come è vero che il gruppo Gardini era uno dei più attivi protagonisti della borsa merci di Chicago, cioè di quella borsa in cui si specula pesantemente con parecchi milioni di dollari in circolazione ogni giorno sui Futures, questi titoli a scadenza ad un determinato momento, di tutte le derrate alimentari del mondo. Allora vedete come si passa rapidamente, forse anche questo si può chiamare Globalizzazione, da un tema locale ad un tema internazionale. Che nessi ci sono?, che interventi possiamo fare?; questo è appunto il tema del dibattito di oggi.
Io comincerei dando la parola a Mario Centorrino per intervenire su questi argomenti."
MARIO CENTORRINO: "Grazie, io ritengo opportuna questa occasione che è un occasione particolare sia per la presenza di relatori qualificati, sia per le caratteristiche stesse del Centro che organizza, sia sicuramente per la sensibilità del pubblico, ritengo che questa sia l’occasione buona per parlare di queste tematiche fuori da qualche luogo comune per tentare, se così può dirsi, di andare oltre affermazioni che ormai , e cercherò di dimostrarlo, risultano scontate. So bene che in quanto dirò può apparire un pizzico di provocazione, so bene che quanto dirò deve essere detto con tutte le cautele necessarie, con le parole giuste, con i toni più acconci ma ritengo, appunto, che un’occasione come questa sia un’occasione che serva per provare ad andare oltre, per provare a dire qualcosa di nuovo su queste tematiche; vorrei avanzare due tesi che sicuramente non appariranno ortodosse ma che credo meritino di essere discusse. Le due tesi sono queste, ma, prima di indicarle continuo a ricordare che bisogna usare tutta la prudenza in questa materia, che è una materia delicata. Ci ricordiamo anni passati quando ci domandavamo dove era la mafia e, se lo domandavamo a Palermo, tutti rispondevano: la mafia a Palermo? No la mafia è a Roma, la mafia è a Milano, la mafia è alla borsa di New York e noi ostacolavamo questa tesi perché dicevamo no! Noi dobbiamo cercare la mafia a Palermo perché "Cosa Nostra" è qua, perché Riina è stato catturato a pochi metri dal tribunale, perché questo localismo è qualche cosa di decisivo.
Tenendo presente questo, tenendo presente questo pericolo a me sembra di poter dire due cose che a mio parere sono più originali rispetto a quanto viene finora detto e cioè che questo pericolo della illegalità nel mercato mondiale, di cui ha parlato appena Calabrò, sia pericolo ben forte, che trova scarsissima attenzione, se non addirittura connivenza, da parte di quello che possiamo chiamare l’ordine economico internazionale. Le ragioni le ha già anticipate Calabrò. Dentro i capitali che si muovono ci sono capitali illegali, ma ci sono anche capitali non necessariamente illegali che però per loro ragione vogliono preferire l’anonimato; si è realizzato una unione di canali , capitali "caldi" e capitali illegali passano dallo stesso canale e basta questa considerazione per fare intuire con quali difficoltà ci si muove nel momento in cui si vuole mettere mano in qualche modo a questo problema, quali difficoltà si aprono per chi tenti appena un attimo di porre delle regole........
(interviene Calabrò): "Mario vorrei mettere in primo piano la definizione di capitali caldi"
(riprende Centorrino)......I capitali "caldi", non sono necessariamente illegali, cioè non hanno necessariamente origine illegale però sono dei capitali che mantengono delle forme di anonimato. Il classico capitale "caldo" è il capitale che nasce da un’evasione fiscale; il classico capitale "caldo" può essere una speculazione finanziaria che in quel momento si vuol tenere segreto. Il punto da cogliere, il punto che crea difficoltà e che questi capitali "caldi" che, ripeto, non sono necessariamente illegali trovano lo stesso canale di riciclaggio nei capitali illegali. A questo punto si è verificata una sorta di sinergia fra economia legale ed economia illegale che finora non era conosciuta e tutt’ora risulta difficile, in qualche modo, da scoprire e che le indagini giudiziarie non hanno sfiorato. Per ultimo e lo dico con molta retorica si accetta il pentitismo ma il pentito al tempo stesso richiede che non si possa mai andare oltre una certa soglia.
La seconda tesi, forse ancora più provocatoria, è questa: noi da anni insistiamo su un paradigma, ovvero, la lotta alla criminalità che è un prerequisito allo sviluppo economico. Io credo che sia giunto il momento di sostituire questo paradigma , che pure per anni è stato validissimo e nessuno può rinnegare, che ha ancora una sua validità, con un altro tipo di paradigma. Si sono sviluppati nell’economia dei processi di adattamento con l’alta criminalità creando delle forme di sviluppo distorte. Insistere ancora sulla lotta alla criminalità come prerequisito allo sviluppo fa perdere di vista un secondo obbiettivo che è un obbiettivo molto più urgente, che è un obbiettivo di maggiore pregnanza. Cioè quello di andare a scoprire , di andare a vedere, di andare a sanzionare processi di adattamento che nel frattempo la stessa economia ha creato per convivere con l’organizzazione mafiosa. Questa idea che ci sia la riga per cui l’economia che sta da un lato è un’economia tutta buona da collegio delle Orsoline che deve subire la pressione, il condizionamento, la penalizzazione dell’illegalità e della criminalità mafiosa è un idea, a mio parere, da abbandonare e cercherò di dimostrarlo.
In tanto con riferimento alla seconda tesi perché sono sicuro che sulla prima ne parlerà sicuramente Colajanni, vediamo, questo paradigma.
Intanto c’è bisogno di fare una sorta di chiarimento, molto spesso si pensa che il prerequisito, quindi la lotta alla criminalità come prerequisito allo sviluppo economico, sia da intendere come una sorta di incentivo allo sviluppo. Eliminiamo la mafia e ci sarà lo sviluppo. Questo è assurdo perché il prerequisito significa appunto come dice la stessa parola pre - requisito qualcosa che ci deve essere a parte. Mettiamoci nei panni di un imprenditore tedesco, l’imprenditore tedesco il giorno in cui dovesse leggere nel giornale "E’ stata definitivamente sconfitta la mafia, non c’è più mafia in Sicilia", ovviamente sto parlando per paradosso, di fronte a questa notizia non reagisce per niente perché gli stiamo comunicando una cosa che nel suo paese è relativamente ed assolutamente normale. Se gli vogliamo creare un incentivo ad investire in Sicilia dobbiamo partire del prerequisito dell’assenza dell’illegalità, ma l’incentivo è un altro, non basta la lotta alla illegalità come incentivo per venire in Sicilia, il differenziale è un altro quello è soltanto una condizione che è una condizione che si pone pacificamente. Ma c’è un secondo aspetto sul quale dobbiamo riflettere: come mai gli imprenditori quando vengono interrogati, gli imprenditori del Sud, e gli si chiede ma quali sono i vostri problemi più importanti?, questi imprenditori mettono la mafia al quinto e al sesto posto preceduto da infrastrutture, organizzazioni burocratiche, le tasse e così via.................. . C’è una rimozione del problema, o un adattamento al problema?. E guardate che questa classifica non varia se l’inchiesta viene fatta a Palermo o se viene fatta a Napoli e così via........ . Io mi sono divertito un poco a catalogare tutte queste inchieste; a Palermo, in Sicilia, le 30 maggiori imprese di successo non citano mai la mafia neppure per dire esiste, quindi che cosa si può pensare?. Si può pensare che la mafia non aggredisce le imprese di successo proprio perché sono imprese di successo, che non possono citare la mafia se no la loro immagine , in qualche modo, perderebbe importanza.
Possiamo trovare un teorema in base al quale si diventa imprese di successo proprio perché non si è graditi dalla mafia? Quando spostiamo l’angolo di visuale troviamo che probabilmente si sono sviluppati dei processi di adattamento che nessuno conosce e che sarebbe bene conoscere, che fanno si che questo non venga indicato come ostacolo allo sviluppo. Tre giorni fa si è svolto un seminario della CONFINDUSTRIA sul Sud e i risultati del sondaggio della stessa furono i seguenti: su un campione di imprese meridionali l’unica regione che cita significativamente la criminalità organizzata, e per quanto dirò tra poco, questa è una regione che va fuori dal discorso che stiamo facendo perché in questa regione c’è un problema civile è la Calabria. Fuori dalla Calabria tutte le altre regioni citano la mafia al sesto o al settimo posto come ostacolo di sviluppo.
Criminalità sì! Criminalità nel Mezzogiorno sì, ma se andiamo a guardare la mappa degli eventi troviamo che questa criminalità è diffusa in tutto il Paese. Qual’è la regione in cui c’è maggiore usura?: il Lazio. E quali sono le regioni dove ci sono maggiori sequestri di droga che fanno pensare che ci sono delle organizzazioni significative?: Lombardia e Piemonte. Dice la Guardia di finanza che in Sicilia non si fa più un sequestro significativo di droga ormai da alcuni anni e che se mai le uniche emergenze che si segnalano sono dovute al traffico internazionale tra Sicilia e New York. Probabilmente si sono riaperti i vecchi canali proprio ad Alcamo e si dice anche, - recentissima la tesi, - che c’è un ridisegno di "Cosa Nostra", una forma di mimetismo, una forma di tirarsi fuori da una ostentazione, da una visibilità , di farsi i loro affari. Certo che in certi mercati questa organizzazione comincia a non avere più il dominio, sembra essere fuori dal traffico di droga per competizione con altre organizzazioni, sembra avere un ruolo - relativamente più ridotto - in altri traffici; probabilmente continua invece nel settore degli appalti ancora più di quanto non possa apparire. Molto spesso noi scambiamo per condizionamento criminale anche dei fenomeni che sono relativamente minimali. Mi ha incuriosito mettere luce, on. Figurelli, sui comuni sciolti per mafia. Questo è un fenomeno gravissimo, una sospensione della democrazia, un comune che viene commissariato per sospetto di infiltrazione mafiosa. Sapete quanti sono questi comuni in Italia sono 11 e 6 di questi comuni sono con meno di 500 persone. Ora significa che questo fenomeno esiste ma è un fenomeno che dobbiamo guardare con un’altra lente, che probabilmente dobbiamo guardare con un altro angolo di visuale. Quali sono i modelli di criminalità più diffusi?: sono le estorsioni, gli inserimenti negli appalti. Ma siamo veramente sicuri che non si siano sviluppati, proprio in queste variabili che cito, dei modelli di adattamento, cioè che gli imprenditori per primi ormai non convivono, non hanno imparato a convivere con il sistema delle estorsioni? . Questo ce lo dicono le indagini, ancor più di ogni possibile ipotesi. Ora ripeto se questo è vero, se c’è un elemento di validità, e lo dico con estrema cautela, non per citare delle forme di caduta di tensione, non per citare delle forme di cambiamento di obbiettivo, resta il fatto che a questo punto noi dovremmo sostituire questa continua evocazione della lotta alla criminalità, come prerequisito per lo sviluppo, con un’altra evocazione. C’è lo studio, l’analisi dei processi di adattamento sviluppati dall’economia in presenza mafiosa ed eventuali sistemi di sanzione che impediscono o che rendono costosi questi processi di adattamento. E’ difficile impedire questi processi di adattamento ma è possibile renderli più costosi. Se noi li rendiamo più costosi solo a questo punto possiamo sperare in una sorta di rivolta del sistema.
L’analogia probabilmente è forzata nasce per il gusto della battuta ma ricordiamoci "Tangentopoli". Proprio "Tangentopoli" finisce nel ’92 perché qualche cosa si altera nel meccanismo, perché probabilmente si pagano delle tangenti più alte del necessario e si pagano senza avere il servizio di corrispettivo. Noi possiamo pensare che il sistema delle estorsioni potrebbe finire il giorno in cui le organizzazioni sbagliassero ad imporre tariffe o non fossero più in grado, per una tariffa pagata, di assicurare protezione. Certo ci sono delle aree di particolare gravità, ripeto la Calabria è un’area a parte, in Sicilia ci sono delle aree di particolare gravità e le conosciamo benissimo. Ma queste aree di particolare gravità, queste aree di patologia sono presenti in tutto il mondo. Per esempio avviene raramente che una persona vada a New York e che si avventuri nel Bronx, addirittura non trova neppure il taxista che sia disposto ad accompagnarlo nel Bronx. Inoltre è chiaro che nessun imprenditore di buon senso farà un investimento nel Bronx, ma nessuno potrà mai dire che non si investa a New York, perché a New York c’è il Bronx. Evidentemente i rapporti sono di altro tipo come di altro tipo a questo punto dovrebbero essere le strategie. Noi finora abbiamo vissuto di lotta alla mafia, questa lotta alla mafia è stata soprattutto, lo possiamo dire oggi, una lotta alla storia della mafia, noi oggi discutiamo, analizziamo, sanzioniamo cose che sono avvenute dieci anni fa, quindici anni fa; la mafia di oggi, la cronaca della mafia di oggi, la cronaca dei rapporti tra mafia ed economia di oggi è una cronaca molto sfumata che passa per grandi linee e molto spesso ripete dei luoghi comuni anche nelle cifre senza che tutto questo sia accompagnato da una indicazione precisa di strategia: oltre alla lotta alla mafia che cos’altro bisogna fare per portare legalità in un territorio? Possiamo fare delle sperimentazioni, possiamo circoscrivere delle aree e possiamo vedere se in quelle aree il potere dello Stato si afferma contro il potere dell’illegalità. In qualche caso si è realizzato pensate a Gioia Tauro. Chi avrebbe mai potuto pensare che un’area della Calabria a così alta presenza mafiosa si potesse trasformare in un polo di sviluppo? Quindi significa che quando c’è un’azione mirata dove ci sono delle risorse investite, quando c’è un coordinamento tra istituzioni, un’area può essere protetta e può diventare area di sviluppo.
Accanto alla tesi della mafia come ostacolo allo sviluppo io credo che ci sia da mettere in conto un’altra tesi che vada in qualche modo oltre e che ci dica che la mafia ostacola lo sviluppo, ha creato dei processi di adattamento e dobbiamo intervenire, dobbiamo cercare di comprendere e soprattutto cercare come smontare questi processi di adattamento.
Un’ultima considerazione, anche questa delicatissima, teniamo conto che la lotta alla mafia, di per sé, porta inevitabilmente degli ostacoli allo sviluppo, la porta in termini di immagine, la porta in termini di rapporti tra imprese, la porta in termine di blocco del credito, la porta instaurando un sistema di rassegnazione. Molto spesso, infatti, quanti di noi, in fondo, non credono nell’impossibilità di una redenzione. Inoltre il sistema siciliano sotto questo profilo, malamente interpretato e malamente letto, ha fatto tanto.
In conclusione, se una conclusione ci può essere a questa analisi così appena abbozzata e così elementare, è che forse è necessario a questo punto fare uno sforzo per andare oltre un paradigma giusto, che però probabilmente è superato, per l’evolversi della storia stessa."
LUIGI COLAJANNI: "Io vorrei per prima cosa ringraziare per l’occasione che mi si è data di partecipare ad un dibattito pubblico qui a Palermo. Ho fatto per molti anni assemblee prima che le vicende della vita mi mettessero fuori, quindi ogni volta che la posso fare devo ringraziare chi mi dà questa occasione, perché realmente il confronto è la cosa più importante che noi possiamo avere e credo che già nei due interventi che ci sono stati i temi di un confronto, di un approfondimento, stiano già venendo fuori. Io vorrei concentrarmi su un punto che poi si applica a due elementi diversi ed è che l’intervento, non direi nemmeno intervento mafioso, l’intervento del capitale di origine mafioso, questo mi pare il modo più corretto per definire la questione, avviene in sistemi che hanno determinate caratteristiche. Cioè trovano una possibilità di inserimento dipendente dalle caratteristiche di quel sistema. Il ché pone immediatamente, anche per quanto riguarda il modo di poter combattere, ostacolare questo movimento di capitali, la consapevolezza che bisogna agire su due livelli diversi: un livello che riguarda la natura del sistema in cui si inseriscono i capitali mafiosi e un livello che invece deve intervenire nel momento in cui si realizza l’entrata, la formazione e l’entrata dei capitali mafiosi nel processo. Se noi non manteniamo rigorosamente separati nella nostra analisi questi due livelli si creano le confusioni di cui parlava Centorrino per quanto riguarda la concezione della mafia come ostacolo allo sviluppo.
Vediamo per esempio la questione dei movimenti internazionali dei capitali. Calabrò ha detto molto chiaramente come avviene il processo. Quanto può essere il peso del capitale di origine mafiosa, per la considerazione che facevo prima, in un movimento che implica ogni giorno uno scambio di oltre mille miliardi di dollari? Il che vuol dire una cifra equivalente al prodotto interno lordo italiano, quindi ogni giorno sui mercati internazionali ci si gioca l’Italia per avere l’ordine di grandezza, ci si gioca l’Italia di un anno, attenzione l’Italia di un anno. Quindi questa è la dimensione e dobbiamo anche sapere che non sono i mafiosi che operano su un mercato di questo tipo: o pagano le banche o pagano le istituzioni finanziarie internazionali. Allora qui a monte c’è un problema. Il primo è quello di sapere se è possibile regolamentare un mercato finanziario, che in questo momento regolamentato non è in alcun modo. Ed è solo quando si sa come si può regolare il mercato nel suo complesso che si possono porre poi le questioni di vedere dove si può intervenire. Certo che la sheep - money, scusate io lo cito in inglese, ha tutte quelle formazioni, quelle provenienze di cui parlava Centorrino. Ma finchè il mercato internazionale è questo e ha questa dimensione, 1.200 - 1.300 miliardi di dollari al giorno, tutte le istituzioni finanziarie hanno interesse di avere la maggiore quantità di capitale che è possibile. Hanno interesse ad averlo per un motivo molto semplice. Che il volume degli utili e dei profitti, in valore assoluto, non il saggio, dipende esclusivamente dalla quantità di capitali che si riesce a movimentare.
In sostanza il capitalismo è quello che è, non dobbiamo supporre che ci sia una formazione a questo proposito. Allora il terreno diventa duplice: cosa bisogna fare per andare ad intervenire nel momento in cui i capitali di origine mafiosa affluiscono nel sistema finanziario?. Dico che comunque l’esigenza è di arrivare ad una regolamentazione di questo mercato che oltre tutto è quello che trasmette con velocità mai vista fino ad ora . La Corea costa già mezzo punto di sviluppo ai paesi della comunità europea ed è probabile che continuando ad andare così si scosterà ancora più di mezzo punto.
Quindi l’esigenza è di intervenire a quel livello. Una prima cosa è quello di disciplinare questo movimento aumentandone i costi, cioè l’idea che ci sia un imposizione, per ogni transazione, che avvenga sul mercato finanziario. Un sistema di questo tipo e quindi le riflessioni cominciano ad essere a questo proposito. Però il capitale mafioso, di origine mafiosa, si inserisce in questo sistema perché il sistema è questo, non è che ha creato un sistema su cui inserirsi.
Un discorso analogo penso che si possa fare qui, sono d’accordo con Centorrino quando parlava del rapporto che si inserisce tra la mafia e lo sviluppo, citando anche una cosa molto interessante, cioè il questionario delle imprese. Da qui ci si rende conto che l’imprenditore è una cosa estremamente complessa di ragioni storico - sociali in cui poi le singole specificità storiche delle singole regioni contano. Molti sono stati quelli che hanno dato una definizione sull’imprenditoria mafiosa: "il mafioso imprenditore si caratterizza per un preciso stile di vita dominato dai simboli dell’agiatezza e dai poteri vistosi, alberghi di lusso, ristoranti di lusso, automobili di lusso di un particolare tipo". Io dico la mafia centra e sono d’accordo anche con il tipo di analisi che si è fatto, non tanto come fattore determinante, per quanto riguarda l’aggravio dei costi delle operazioni dell’economia. Centorrino, nel libro che ha scritto, cerca una teorizzazione di un processo, la teorizzazione di un processo di questo tipo, ma non è tanto per questo quanto perché uno dei componenti che si aggiunge ad altri che operano nella stessa direzione a determinare un ritardo nella formazione di una imprenditorialità moderna nel Mezzogiorno d’Italia. Questo è il modo in cui dobbiamo trattare le questioni, è un modo istituzionalista di trattare i problemi dell’economia? Si è proprio un modo francamente istituzionalista , un modo che si basa sull’analisi complessiva delle situazioni.
C’è un libro molto bello di uno storico dell’economia inglese il quale descrive l’accentramento economico dell’Inghilterra nella seconda metà del secolo diciannovesimo quando gli industriali inglesi, che poi hanno fatto la rivoluzione industriale ed erano nell’avanguardia dello sviluppo del capitalismo, si posero il problema di imitare il modo di vita degli aristocratici inglesi e il libro dimostra la caduta della capacità imprenditoriale che ne seguì. Ora trasportate questo in una regione dominata fino alla metà di questo secolo dall’economia di tipo feudale e dominata successivamente dalla formazione di un blocco di potere in cui la mafia c’entrava, ma che era fondato sul mancato sviluppo delle forze produttive, fondato sui trasferimenti di capitali, questo è il terreno in cui la mafia si inserisce. Questo è il terreno in cui deriva l’aggravamento del divario fra paesi che non dispongono di una imprenditorialità adeguata. Il paragone tra Sicilia e Nord - est dell’Italia non è quello che dovrebbe far riflettere, ma dovrebbe far riflettere soprattutto le condizioni storico - sociali che hanno portato alla diversità di questi due tipi di sviluppo. Non significa che non c’è neanche qui il problema di agire a livello dell’afflusso della mafia che non può essere separato dall’intervento a livello di sistema.
Io non voglio togliere nulla all’efficacia dell’azione penale per chiamare le cose con il loro nome, deve essere però estremamente chiaro che l’azione penale non può essere vista separata da un intervento generale. Ho detto prima come la vedo a livello internazionale con tutte le difficoltà che ci sono, non può essere separata da un intervento a livello del sistema che io non esiterei a chiamare, scusate se adopero questo nome che non riesco a chiamare diversamente, una politica di riforme, cioè dalla necessità di interventi sul sistema e su come si organizza. Certo sappiamo bene che ogni intervento sul sistema è una cosa complicata che richiede tempo ma credo che a questo punto diventi essenziale una cosa. Io ho creduto per molto tempo, nel passato, e le autocritiche bisogna anche sapersele fare, che un ritardo nella formazione dell’imprenditorialità meridionale potesse essere supplito da un certo tipo di interventi diretti dallo mano pubblica. Le autocritiche sono necessarie; quindi a questo proposito l’autocritica deve essere fatta sull’idea che il Mezzogiorno non può sopportare tempi lunghi; la verità è che il Mezzogiorno o si affronta con una politica coerente che abbia tempi lunghi o rimane allo stato attuale. Da qui deriva anche una certa critica all’andazzo attuale della politica che è fatta tutta, per quanto riguarda la Sinistra, di gioco di schieramento e di mosse piuttosto che d’impegno nel vedere quali sono gli obbiettivi di riforme da perseguire nei tempi lunghi e per realizzare con la coerenza di un impegno politico. Perché io quando vedo certi documenti sul Mezzogiorno, dove si dice testualmente che gli interventi debbono essere indirizzati in preferenza verso i comuni che hanno quella "capacità propositiva", badate bene "non più efficienti", o dove si dice che i fondi debbono essere utilizzati per quelle imprese che hanno buoni programmi ma molte sofferenze, modo eufemistico per dire altre cose, che volete che queste cose dispiacciano alla mafia? Le imprese che hanno buoni programmi ma molte sofferenze sono un terreno di elezioni per interventi di un certo tipo, per rapporti di certo tipo e per salvataggi di un certo tipo che debbono essere fatti. Quindi io dico: necessità di una politica coerente portata avanti coerentemente sapendo, che è una politica dai tempi lunghi per questo, è il tipo di intervento che è necessario. Poi ci sono naturalmente gli interventi per quanto riguarda l’afflusso.
Ora sappiamo tutti che, e Centorrino lo ha ricordato molto incisivamente, sappiamo tutti che la mafia ha una grande capacità di adattamento alle modificazioni, sappiamo tutti che nel corso di questo adattamento sorgono le contraddizioni, nel senso che ad ogni piena si curva la pianta. Avvengono delle cose diverse, naturalmente. C’è un esempio classico di analisi che è il passaggio dalla mafia del feudo, basata sul codice d’onore oltre che sullo sfruttamento dell’economia feudale, alla mafia della città. Prima la speculazione edilizia, poi la droga ha portato un insieme di contraddizioni profonde che dobbiamo appunto saper valutare. Che tipo di contraddizioni ci sono state. Prendiamo i Corleonesi. La vicenda dei Corleonesi è stata di riportare nella nuova attività economica della mafia della città e nella nuova tecnologia del delitto, chiamiamola così perché fatta da timer e comandi a distanza, uno spirito che era fondamentalmente vecchio, cioè quello della cerchia ristretta che dominava la "cupola", che poteva imporre un certo modo di fare. Secondo me la contraddizione più forte sta nel fatto che quando il condizionamento non dipende più da uno sfruttamento di tipo feudale ma dalla caratteristica del mercato in cui si opera, il codice d’onore salta. Per esempio per quanto riguarda i pentiti anche in loro c’è un adattamento: Buscetta è il pentito che parla a nome della vecchia mafia, che rimprovera di aver abbandonato il codice d’onore e parte del passato; loro sanno che sul terreno del mercato la loro libertà vale una certa cosa, sanno quello che debbono fare. Quindi il pentimento diventa un’altra cosa senza nessuna radice di formazione culturale; del resto le vicende successive, mi pare, che proprio questo dimostrino, non c’è una radice ideologica, funzionale chiamiamola così. Il pentimento di questo tipo con una valutazione di mercato, tanto è vero che poi questi nuovi pentiti, prima ancora di pentirsi, appena vengono arrestati, cominciano a parlare di Giulio Andreotti in un evidente obbiettivo di "captarsi benevolenza" e questo lo vediamo nei casi più recenti.
Quindi c’è un adattamento di questo tipo; che significa?. Questo è il problema che mi pongo. Che significa quel processo di globalizzazione, in questo modo? processo di evoluzione del sistema mafioso? Mi azzardo a fare qualche considerazione. Evidentemente un processo di globalizzazione in cui la mafia non ha più la potenza di prima, per la ragioni che sono state dette, per la ragione dei mercati, per la concorrenza, che esiste, di altre mafie e di altre organizzazioni, non più permettersi il lusso di operazioni come tipo Riina, delle operazioni tipiche dei Corleonesi. Quindi da questi bisogna prendere la distanza in un modo o in un altro, bisogna saper prendere le distanze. Ma dico qualcosa di più. Questo comporta anche un abbandono del vecchio tipo di rapporti con il potere politico, perché per potere esistere in una globalizzazione di questo tipo l’organizzazione mafiosa, per dirlo anche in termini di mercato, deve poter agire in modo più agile. Ed il rapporto con il potere politico ad un certo punto diventa un peso per un’operazione di questo tipo, deve concentrarsi molto di più sugli affari internazionali. Quindi penso sia possibile andare a dover fare i conti con un cambiamento di posizione di questo tipo.
Qui si pone una questione, va bene la lotta penale è indispensabile, ma è necessario anche un intervento a livello delle riforme in campo internazionale. Per il significato che può avere questa frase. Che cosa può unire tutte queste cose? Io sono convinto che nella nuova situazione, nella globalizzazione, nel perseguimento di questi obbiettivi, la consapevolezza intellettuale, dei nuovi termini intellettuali - politici - culturali di questa situazione io credo che sia una cosa importante, essenziale. Uno dei passi più grossi che ha fatto Palermo nel corso di questi anni è stato appunto questo: un certo risveglio e l’avvio verso un deciso cambiamento.
(Testo non trascritto per cambio di cassetta di registrazione)
Ma perché tutti gli intellettuali palermitani sapessero chi era il padrone. Naturalmente i comunisti furono sconfitti in quella campagna elettorale; e però quella fu anche la testimonianza che qualcosa di un certo spirito era passato ad indebolirne la capacità.
Ma io ricordo proprio in quella occasione un articolo "dell’Ora" in cui si avanzava il dubbio che i comunisti fossero stati morsi dalla tarantola .........Ora questo è cambiato, non per virtù dello Spirito Santo, questo è cambiato per l’impegno e per il sacrificio di tanti e in un posto come quello della Fondazione che ci ha riunito questa sera è inutile che venga a fare i nomi. Queste cose sono cambiate. Ma io credo che la via più importante sia quella di continuare in questa direzione; rimane il modo che ci sia l’impegno sempre più rigoroso della cultura nella politica di riforma, per quello che dicevo prima, per quanto riguarda la direzione diretta verso la mafia a livello penale, ma in cui la grande capacità deve essere quella di unire le cose in un’unica prospettiva che sappia come debbono essere portate avanti. Una prospettiva che sappia per esempio che la libertà è indivisibile e che non si possono fare certi conti se non si mantengono fermi certi valori. Una politica di riforma e la nozione di diritto nel rispetto della legge e della concezione dell’indivisibilità della libertà. Io penso che Palermo ha fatto grandi passi in questa direzione. Penso questo. E devo dire allora, permettetemi di rovesciare il vecchio detto Gramsciano, questa è l’occasione per l’ottimismo dell’intelligenza, non per il pessimismo dell’intelligenza, nel dover constatare come le cose effettivamente si sono mosse".
ANTONIO CALABRO’: "Dell’intervento di Colajanni c’è un punto particolarmente importante che ci può consentire di continuare il ragionamento, analizzando i flussi internazionali. Che il capitale di origine mafiosa nel momento in cui arriva nel grande circuito non è più controllabile. Infatti dice giustamente: no il capitale mafioso, ma il capitale di origine mafioso. Ad un certo punto i capitali sono uguali tra loro non c’è un bollo, un marchio, una cosa, un colore, un segno che lo distingue da qualcos’altro.Il problema è quello di controllare l’entrata dei capitali nel processo e infatti a questo punto possiamo fare due ragionamenti: uno di origine penale e uno di origine civile - economico, di sanzione penale, da certi punti di vista, ma anche di sanzione da parte del sistema nei confronti di alterazioni che riguardano il sistema stesso.
Torniamo all’esempio che avevo fatto all’apertura del dibattito; posto che le indagini confermino che il gruppo Ferruzzi abbia particolari rapporti con le famiglie mafiose, una cosa deve essere detta subito. Il gruppo Ferruzzi arriva a Palermo in una data ben determinata e si sa che arriva a Palermo, si sa anche che sulla collina di Mondello c’è un gigantesco complesso immobiliare costruito si sa da chi. Quando viene costruito dalla famiglia Greco, si sa anche che ad un certo punto quel complesso immobiliare passa di mano e passa di mano non da Tizio a Caio ma dalla famiglia Greco al gruppo Calcestruzzi, accertamento che bastava fare con un collegamento della società iscritta alla Camera di Commercio. Bene tutto questo succede alla fine degli anni ’80 ed è di dominio pubblico.
Dovrebbe essere stato chiaro subito a inquirenti e forze economiche che in quel momento si stava alterando profondamente il processo economico di questa città perché si allargava il margine di pressione da parte della mafia. Per tornare alla citazione di Centorrino che voleva che le imprese di origine nazionale fossero un buon antidoto alla mafia, io l’ho scritto più volte è quella la strada da seguire; ma mi sono reso conto di aver sbagliato nel pensare una cosa del genere.
Inoltre si doveva capire, a livello di autorità nazionali, che i rapporti, l’eventuale rapporto perverso tra un grande gruppo economico internazionale, una multinazionale come la Ferfil e la famiglia mafiosa poteva alterare i corsi di borsa in Italia e all’estero. Tutto questo se fosse stato utilizzato con un buon campanello di allarme avrebbe potuto portare rapidamente la Guardia di finanza da una parte per quanto riguarda la quota di capitale fuori logica fiscale, la Magistratura siciliana per certe indagini, la Consob per la Borsa italiana; probabilmente l’autorità di controllo della Borsa Merci di Chicago - è la seconda per New York - sono intervenute tempestivamente non per bloccare capitali già immessi nel circuito ma per bloccare i capitali prima che entrassero nel circuito, cioè per evitare un avvelenamento in corso del processo economico.
Quindi raccolgo l’invito di Colajanni su questo. Probabilmente bisogna concentrare l’attenzione non soltanto dal punto di vista dell’azione penale; però anche dal punto di vista della autorità di controllo dei mercati finanziari e cioè se volete, rispetto ad una politica più penetrante di controllo, le riforme di cui parlava Colajanni, che secondo me comprendono anche un maggior potere di chiarificazione di intervento di sanzione da parte della autorità finanziaria e di controllo. Una Consob almeno in grado di avere un potere d’indagine che invece la Sec di New York ha, la Sec è l’organo di controllo di New York che ha per certi versi capacità di intervento analoghi a quelli della magistratura; la nostra Consob no.
Allora, i due interventi che ci restano sono di un componente della Commissione Antimafia e di un magistrato che ha fatto indagini in Sicilia e che adesso sta all’interno del C.S.M.. E’ possibile definire politiche d’intervento da questo punto di vista?. Ed è possibile marcare l’azione politica, diciamo più genericamente, in senso antimafia, ma soprattutto per quello che riguarda i rapporti tra mafia - economia - sviluppo?".
SERGIO LARI: " Evidentemente gli interventi che mi hanno preceduto hanno posto sul tappeto una tale massa di problemi che non è facile in dieci minuti dare una risposta a tutto; nè mi illudo di riuscire a farlo perché comprendo che si tratta di problemi abbastanza complessi. Allora cercherò di fare un intervento relativo all’invito fatto dal dott. Calabrò: che fare rispetto a questa analisi globale che è stata svolta prima di me? Si è parlato, fino a questo momento, del riciclaggio degli investimenti, di questa massa di denaro, sappiamo che il 2% addirittura del prodotto mondiale lordo sarebbe composto da capitali illeciti. Devo dire che mancano delle stime esatte. Effettivamente non credo che si possa parlare del 2%, tra l’altro, rispetto al prodotto mafioso interno ci sono stime che variano. Mi sembra che si sia parlato di 70.000 miliardi; quindi già c’è questa difficoltà, però potremmo dire che certamente sono ingenti masse di capitali che inquinano il mercato internazionale.
Sul versante internazionale io non sono molto, diciamo così ottimista, nel senso che ritengo che allo stato attuale la nostra legislazione sia molta arretrata, ma che soprattutto manchino degli accordi internazionali efficaci che ci consentano di poter portare le indagini con efficacia al di fuori dei nostri confini. Basti pensare che la Svizzera per esempio negli ultimi anni ha rigettato circa 74 - 75 richieste di collaboratori internazionali e sono molti i paesi come l’Inghilterra, il Canada, l’Australia che in realtà non collaborano come si dovrebbe nelle indagini che vengono fatte dall’autorità giudiziaria italiana. Questo è un problema serio rispetto al quale la Magistratura si trova impotente e che sicuramente richiede degli interventi di alto livello internazionale, qualcosa che ci possa fare intervenire su questo versante.
Io ritengo pertanto, cercando di sintetizzare, che per potere avere risultati sul campo del riciclaggio mondiale - internazionale devono essere introdotti degli strumenti normativi, che consentono di portare avanti una azione che allo stato attuale non è in grado di portare avanti. Però certamente non si può stabilire una scala di priorità, che è più importante questo rispetto a ciò che riguarda il mercato interno o viceversa. E’ una strada percorribile parallelamente all’altra, però si tratta di una strada che potrà dare risultati nel medio termine se non a lungo termine. A proposito di questo vorrei rispondere ad una affermazione fatta dal prof. Centorrino. E’ sul versante interno che in questo momento vi sono gli strumenti per potere intervenire e si deve intervenire con la massima efficacia possibile; credo che dobbiamo partire dal presupposto che le organizzazioni criminali, "Cosa Nostra", ‘ndrangheta, sacra corona unita, camorra che sono le più grosse organizzazioni che operano in Italia, sono tutte caratterizzate da un dato comune ovvero il radicamento sul territorio come elemento fondamentale per poter mantenere la propria egemonia e il proprio potere.
Questo è un dato costante; l’ho rilevato nella mia esperienza di Procuratore della Repubblica di Trapani e lo rilevo nella mia esperienza attuale di componente da tre anni della Commissione criminalità organizzata del Consiglio, è un dato che caratterizza tutte le organizzazioni criminali: senza controllo del territorio, che comporta anche il controllo dell’economia di quel territorio, non si può sperare di sopravvivere da parte di queste organizzazioni.
Dal chè nasce la ovvia osservazione, forse scontata, che se si riesce ad incidere efficacemente sul territorio, stroncando lo strapotere di queste organizzazioni, anche la proiezione sui mercati internazionali di queste organizzazioni stesse è destinata necessariamente ad esaurirsi perché viene tagliata la pianta alla radice. Potrei citare, giusto per ravvivare il dibattito, delle indagini sulle estorsioni avvenute a Trapani da cui viene fuori che il mercato delle piccole e medie estorsioni non veniva gestito direttamente da "Cosa Nostra", perché non vi era interesse diretto; ma non poteva essere abbandonato, perché controllare il mercato delle estorsioni, cioè il racket, significava anche controllare il territorio; allora viene dato in subappalto alle organizzazioni criminali comuni, questo emerge dalle intercettazioni ambientali che sono state operate dalla Procura. Che sostanzialmente dovevano chiedere il permesso per potere operare determinate estorsioni o meno, per poter commettere degli omicidi, in sostanza "Cosa Nostra" attraverso il subappalto controllava anche il territorio. Ora se è vero che il controllo del territorio è un elemento fondamentale, altro elemento cui fare una riflessione è che il controllo del territorio non avviene soltanto attraverso il pizzo o le estorsioni, ma avviene anche attraverso la diretta o indiretta gestione delle attività economiche operanti nel territorio. Forse questo potrebbe dare una spiegazione a quella domanda che si poneva il prof. Centorrino. Ma perché la mafia è indicata come fattore di raffreddamento dell’economia da parte delle imprese del Sud, al sesto posto per esempio? Io credo che una spiegazione potrebbe essere trovata sotto due versanti: per un verso molto spesso è la stessa mafia che gestisce queste attività economiche direttamente o indirettamente. Però quando questo non avviene vi è l’accettazione del così detto pizzo, come costo d’impresa talvolta forse anche inferiore ai costi d’assicurazione. Questo forse potrebbe essere una spiegazione del fenomeno.
Resta però il fatto che non si può pensare che si possa avere un bilancio dell’economia siciliana o delle imprese accettando questo stato di cose perché gli effetti distorsivi sulla libera concorrenza impediscono che possa nascere in Sicilia e nel Meridione un’impresa in grado di concorrere. Viene impossibilitata di poter esercitare una libera concorrenza e quindi diventa difficilmente auspicabile uno sviluppo del mercato.
Questo non significa negare le necessità di agire sulle infrastrutture, ma quando si dice incentiviamo le imprese del Sud con gli sgravi fiscali in maniera tale da consentire un maggiore rilancio, io mi pongo il problema che forse agendo in questa maniera non si venga a favorire la mafia, sostanzialmente consentendo alla mafia di ottenere quel surplus che consente di risparmiare nello sgravio fiscale. O se invece non sia meglio mettere gli imprenditori dinanzi alle loro responsabilità; certo oggi quegli iniziali fenomeni a cui abbiamo assistito, mi riferisco alle estorsioni, sono scomparsi, sono venuti meno e questo è un dato che mi preoccupa molto.
Si diceva il discorso della libera concorrenza, della impossibilità delle imprese siciliane di poter decollare, ma non è soltanto questo, cito un altro esempio. L’indagine su Alcamo, uno dei territori ad alto indice di criminalità mafiosa che abbia mai incontrato nella mia carriera, il caso di riciclaggio, diciamo così , di somme di denaro interessate per gli effetti distorsivi sull’economia.
In questo caso capitali di "Cosa Nostra", che in parte venivano dal traffico di stupefacenti, in larga misura provenienti da attività apparentemente lecite, veniva riciclato in questa maniera: venivano aperti dei supermercati che venivano intestati a uomini di paglia, per lo più vecchietti. Si prendevano immediatamente questi capitali sporchi, passavano al nord per l’acquisto di materie prime che venivano immesse sul mercato a prezzi estremamente competitivi che già mettevano in ginocchio una parte dell’economia delle imprese.
Decorso un certo lasso di tempo venivano acquistati ulteriormente, sempre dagli stessi fornitori, grossi quantitativi di merce, questa volta non con pagamenti in contanti ma con pagamenti differiti, dopodiché tutta questa merce veniva addirittura sottoposta nel mercato e si faceva fallire l’impresa. Si era contemporaneamente riciclato un ingente quantità di denaro, messa in ginocchio le imprese del Nord che fallivano perché non venivano pagate, messe in ginocchio l’economia meridionale perché tutta la massa di piccoli e veri imprenditori e commercianti venivano colpiti dagli effetti della illegittima concorrenza. E questo è un esempio che può sembrare banale; ma sono fatti che si sono verificati, ci sono atti giudiziari che hanno portato a condanne etc.., questi sono i fatti. Quindi non si può accettare questo fatto, allora dobbiamo partire da una analisi dividendo l’Italia in due: il Centro - Sud e il Centro - Nord. Nel Centro - Sud è fondamentale insistere sulla lotta alla criminalità, secondo il mio avviso, e qui sto rispondendo al prof. Centorrino, come prerequisito del risanamento dell’economia.
Può sembrare un vecchio discorso; però secondo me è fondamentale che questa strada venga perseguita in maniera assoluta e quindi questo richiede un potenziamento della politica del doppio binario e la dotazione per la Procura, per gli uffici che sono titolari a fare questo tipo di indagini, di strumenti di investigazione aggiornati con i tempi.
Oggi ritengo che per stroncare il racket e le estorsioni siano fondamentali l’utilizzo di sofisticati strumenti per poter agire, noi di fuori, per cercare di scoprire questi fenomeni e stroncarli sul nascere.
Allora dobbiamo renderci conto che l’utilizzo degli strumenti fondamentali non danno effetti positivi anche sui fenomeni internazionali delle attività illecite. E poi cercare di agire nella zona del Centro - Sud, dopodichè certo è vero in parte quello che diceva l’On. Colajanni circa il fatto che oggi molti processi sono processi della storia della mafia. Però vorrei anche dire noi non sappiamo quello che più o meno, durante tutto questo tempo, hanno sotto controllo gli uffici delle ferrovie. Sicuramente i dati che io intravedo sono quelli della scoperta di ingenti fenomeni di riciclaggio interno. Per esempio "il caso Parisi", questo è un caso che abbiamo letto su tutti i giornali, sono stati trovati decine e decine di attività imprenditoriali che hanno portato a scoprire lo svolgimento di una serie di attività illecite.
Proprio nel suo intervento, l’On. Parisi, parlava anche della mafia internazionale; questo è un altro problema serio che abbiamo avuto modo di studiare nella Commissione della criminalità organizzata, nel C.S.M.. I dati sono molto allarmanti, per la precisione si parla di 27.000 miliardi di marchi di investimento soltanto da parte della mafia Russa in Italia.
Il dato interessante che emerge è che i fenomeni di immissione di mafia straniera, e mi riferisco alla mafia Cinese, Russa e Turca si sono sviluppati soprattutto nel Centro - Nord d’Italia. Non ci sono state penetrazioni di queste mafie internazionali nelle zone del Centro - Sud, evidentemente il controllo del territorio, per tornare al discorso di prima, è molto più ferreo.
Il problema dell’immissione della mafia internazionale è un problema grave perché viene a determinare un quadro in cui tutto il territorio nazionale sostanzialmente è occupato in maniera massiccia. Perché noi ci troviamo ad occuparci di "Cosa Nostra", la Calabria è occupata in maniera massiccia dall’ndrangheta che si avvia a diventare sempre più una forza criminale soverchiante, addirittura a divenire una potenza superiore a "Cosa Nostra" secondo le stime. "Sacra Corona unita", che ora con la questione albanese a seguito di una visita che è stata svolta dalla Commissione da me presieduta lo scorso Marzo, sta stipulando delle alleanze di ferro con una mafia albanese fortissima. Attualmente in Albania ci sono coltivazioni di Hashish notevoli, in Albania transita eroina proveniente dalla Turchia, vi è un traffico di armi spaventoso, si aggiunge anche la prostituzione che consente a queste organizzazioni di poter fruttare capitali che poi vengono immessi nelle attività.
In questo quadro dovendosi parlare "di che fare" dobbiamo rilevare che sul versante giudiziario vi è una difficoltà di risposte da parte dello Stato; il nuovo codice della procedura penale impone un certo tipo di processi con centinaia di indagati, noi abbiamo un sistema giudiziario ingolfato nel dovere necessariamente procedere secondo processi del codice di procedura penale che è impostato in un certo modo.
Il problema dello svolgimento dei dibattimenti di criminalità organizzata è un problema drammatico perché effettivamente ci fa venire alla luce i fenomeni criminali sul versante giudiziario con l’opportunità della verificazione. Quindi io credo che innanzitutto ci dovrebbe essere a livello politico un intervento normativo serio per cercare di portare avanti la politica del doppio binario e per avere dei sistemi più veloci e più snelli per la celebrazione dei processi in materia di criminalità organizzata e questo credo che sia un primo passo da fare.
Poi vi è la necessità di intervenire sul versante della normativa che riguarda la prevenzione sulla materia attenzionata. Noi finora abbiamo agito con la legge "La Torre" e sostanzialmente questo è stato il nostro punto più efficace di cui abbiamo avuto a disposizione. Perché? Perché consente di aggredire il patrimonio dei mafiosi pur con l’onere di dimostrare la provenienza illegittima dei patrimoni.
Il meccanismo normale che nella procedura giudiziaria si è verificato quale è? Il collaboratore parla e riferisce un certo organigramma in una certa zona, in un certo territorio. Quando la Procura distrettuale chiede le misure cautelari concessa dal GIP l’ordinanza che concede le misure cautelari trasmesse dal Procuratore "ordinario", cioè il Procuratore di Marsala o di Trapani. Nel caso di Palermo c’è l’identificazione delle due figure che procedono ad attivare la normativa.
E sono notevoli questi patrimoni, abbiamo parlato del caso Piazza, abbiamo parlato delle vicende di Rieti, di Trapani del latitante Francesco Virga capo mafia che fino al suo arresto gli sono stati confiscati buona parte dei beni che lui possedeva. E però rimane un interrogativo al quale non è stata data una risposta: dove è il resto dei beni?.
Vogliamo vedere quali sono le grandi richieste sul versante del riciclaggio a parte l’operazione del "Check TO Check" di Torre Annunziata di cui si è parlato, oltre a guardare la relazione di Dicembre ’90 della D.I.A. sul versante riciclaggio in borsa.
La D.I.A. porta come fiore all’occhiello della sua attività quattro grosse operazioni antiriciclaggio del Centro - Nord, tutte che riguardano l’ndrangheta.
Possibile che da parte dei collaboratori non si sia ancora riuscito a trovare una spiegazione su questo versante? E’ possibile che ci siano delle indagini in corso che noi non sappiamo, rispetto a collaborazioni recentissime? Però sorge il sospetto che probabilmente ci sia stata una gestione di questi capitali illeciti da parte di uno strettissimo vertice di capimafia che sono depositari di questi segreti che ancora non siamo riusciti a penetrare. Credo che se non si riesce a fare questo passo ulteriore l’azione di contrasto alla mafia sarà sempre un azione inefficace. Questo dovrebbe essere il versante giudiziario sul quale dovremmo dedicare tutte le nostre attenzioni".
MICHELE FIGURELLI: "Io credo che dibattiti come questi possono essere molto utili se consideriamo il fatto che ancora oggi noi ci troviamo davanti a tante nuove verità militari sul potere mafioso. Ma insieme sorgono delle verità economiche non solo su quello che Sergio Lari ha detto con riferimento ai beni dei mafiosi, ai beni accumulati, anche su quelli di coloro che si pentono o tra coloro che "collaborano". Ma soprattutto sul meccanismo del movimento del capitale illegale, su forme diverse dell’investimento, verità anche su ruoli o situazioni come quelle su recenti accuse per le quali sono stati arrestati dei grandi imprenditori e che hanno evidenziato, per esempio, la situazione di un imprenditore dell’edilizia che, accusato oltre che di associazione di estorsione aggravata anche di riciclaggio aggravato. Oppure ci sono squarci di verità come quelle che emergono dalla indagine sulla cassa rurale artigiana di Monreale che quasi è apparsa una vera banca mafiosa.
Pochissime verità sulla forma di immissione del capitale criminale nell’economia legale e anche nel capitale legale, per esempio sulle forme molto diffuse e varie di vero e proprio impossessamento di imprese o di immissione forzosa nell’impresa e in una impresa legale o come inquinamento dell’economia e del mercato.
In questo senso sulle tesi che venivano discusse all’inizio di questo dibattito, la mafia appare un ostacolo all’economia e allo sviluppo nel senso che l’imprenditore che gode della forza di un capitale accumulato in maniera criminale, batte sul mercato la concorrenza. L’imprenditoria che paga il denaro non a tasso maggiorato ma anche ad un tasso più basso.
L’imprenditore che ricorre al subappalto e al nero che l’organizzazione mafiosa gli fornisce, batte l’imprenditore che non fa lavorare in nero, che non espone i propri lavoratori al pericolo di morte continua. O comunque riespone sul terreno delle sicurezze per quanto riguarda il lavoro e la vita sul lavoro, l’imprenditore che si è rivolto per esempio al Banco di Sicilia o alla Cassa di Risparmio ed è stato battuto sul mercato; Quindi la mafia ostacola. Non molto tempo fa in una discussione che c’è stata nel senato americano a proposito di una indagine sulla mafia russa, di fronte alle forti preoccupazioni che emergevano da una parte, dall’altra parte invece emergeva la stima sul fatto che la mafia russa avrebbe potuto assolvere ad una funzione, in fondo alla lunga positiva, facendo affermare il capitalismo da un regime totalitario burocratico che aveva compresso l’economia. Ora sembra che stia crescendo la preoccupazione che si stia diffondendo la consapevolezza del pericolo per l’economia, pericolo costituito dalla presenza della mafia e di altre organizzazioni criminali e dal rapporto tra loro.
E’ difficile la stima del prodotto criminale lordo; ci sono molte cifre che vengono citate anche da organismi interni che spesso sono anche in parte contraddittori l’una con l’altra a proposito di quanto ammontino i proventi del traffico degli stupefacenti e del traffico delle armi. Altre preoccupazioni, consapevolezze, allarmi non solo in casa nostra ovvero nelle relazioni attuali del Governatore della Banca d’Italia, ma mi riferisco al fondo monetario internazionale, alla Banca Mondiale e a considerazioni che non isolano l’economia ma che guardano al capitale criminale come potere e all’intervento e al pericolo dell’intervento di questo potere anche sulle istituzioni e quindi alla sua ricaduta sull’economia. Cioè ad un potere di corruzione, riferendomi anche a fatti recenti, che riguardano Hong Kong dove proprio nei mesi scorsi c’è stato un incontro promosso dal fondo monetario internazionale della Banca Mondiale.
Le istituzioni europee, il Parlamento europeo stanno lavorando attivamente per definire la proposta di una convenzione internazionale sulla corruzione ed io parlo di un potere che l’accumulazione del capitale criminale contiene e determina.
I grandi campi dell’attività mafiosa e criminale sono la droga, le armi, ma tratta anche commercio di donne, di uomini, detiene il controllo dei flussi migratori e sono proprio questi i campi d’incontro delle diverse mafie e delle diverse organizzazioni criminali. Questi campi che ho citato richiedono numerosi passaggi e numerosi rapporti con, da un lato, le istituzioni legali e, dall’altro, con organizzazioni illegali.
Via, via che il movimento della droga, delle armi si mette in circolazione, le cosche si organizzano in ciascun punto di questo viaggio molto lungo tra il luogo di produzione e il luogo finale e l’impiego.
A questo si aggiunge la preoccupazione dell’investimento, del movimento monetario e del riciclaggio, ma non si ferma qui, evidentemente, il movimento internazionale del capitale criminale. Perché vi sono campi come quello dello smistamento dei trasporti e dell’occultamento dei rifiuti tossici e nocivi che è un campo particolarmente grave e allarmante dove sono state fatte scoperte anche terribili per la salute di zone intere e ancora su traffici che portano a nuovi investimenti e accaparramenti immobiliari e anche nel campo turistico.
Questa discussione avendo come titolo "L’economia mafiosa dai confini regionali al mercato mondiale" potrebbe portare ad una conclusione su cui ha giustamente polemizzato Centorrino, cioè quello della fuga da Palermo o da territori in cui c’è maggiore forza del potere mafioso.
Oggi guardando a questo movimento dai confini nazionali ai confini mondiali dovremmo dire che il movimento è circolare, dai confini regionali a quello mondiale e di nuovo dentro i confini regionali. E questo è vero non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria, per la Campania e per la Puglia e io dico questo sulla base delle risultanze di alcune visite e di alcune indagini , nelle quali è impegnata la Commissione Antimafia. Questo si è visto soprattutto nel rapporto tra la regione Puglia e non solo l’Albania ma soprattutto il Montenegro.
Il rapporto tra i confini regionali e il mercato mondiale non è sorto adesso ma ha una lunga storia, almeno per quanto riguarda la Sicilia; è una storia che ha segnato un momento di svolta anche nella politica, se pensiamo agli anni ’40 o anche alla svolta dei grandi delitti del ’79 - ’80 e alla missione di Sindona in Sicilia nel suo rapporto con il grande boss della mafia e della Massoneria che era Stefano Bontade.
Io penso ed è utile, per la nostra riflessione attuale, fissare come un punto di riferimento cronologico, di grande svolta, anche nel modo che dobbiamo considerare la mafia e l’economia mafiosa, il 1989. Io penso che la caduta del muro di Berlino deve inserirsi a tutti gli effetti anche un grande spartiacque sulle cose che stiamo discutendo, nel senso che cambiano i connotati del mercato mondiale e i rapporti, le relazioni e le interdipendenze tra il mercato mondiale e le diverse regioni del mondo. E non fa soltanto crollare il ruolo affidato alla mafia; inoltre c’è un rapporto tra la mafia e la politica che era funzionale alla divisione e allo scontro tra i blocchi.
Scongelare questo oggi ha delle grandi conseguenze sui cambiamenti dei poteri, sui cambiamenti dei poteri della mafia e delle altre organizzazioni criminali. Su domande che sono venute soprattutto verso il centro e la parte finale del dibattito mi fanno dire qualche altra cosa. Io penso che un’azione antimafia internazionale sia oggi, nonostante la consapevolezza di cui ho parlato, molto più indietro e arretrata rispetto ai livelli e ai gradi di internazionalizzazione delle organizzazioni mafiose, di fronte alla portata dei fenomeni. Questa è la tesi che io mi sento di sostenere, di pensare ad una liberazione dell’economia dalla mafia. Se la internazionalizzazione è un moltiplicatore, per ogni mafia, di ricchezza, di potere, tuttavia io credo che noi non dobbiamo vedere nella caduta delle frontiere e nella libera circolazione degli uomini, delle cose e del denaro il segreto e il punto di forza della mafia. E questo perché il punto di forza della mafia sta nella carenza dell’unificazione politica, di internazionalizzazione della politica, nell’arretratezza che ha la politica rispetto ai processi di integrazione economica. E’ qui io mi riferisco alle riforme e problemi di coordinamento, di unificazione legislativa e quando dico unificazione legislativa non parlo soltanto del campo pur fondamentale delle leggi penali.
Esiste oggi una clamorosa e curiosa doppiezza, dualità e contraddizione vera e propria di frontiere, per cui da un lato oggi noi abbiamo che ognuno, e quindi anche un grande criminale, si può spostare e può spostare molto denaro da un punto all’altro del globo o dell’Europa con grande velocità. E io mi domando rispetto a questa possibilità di spostare se stesso e il denaro, come si trova invece il Magistrato? Questo riguarda sia il Magistrato del nostro paese che il Magistrato di altri paesi d’Europa. Questo Magistrato ha la possibilità di libertà e velocità di spostare se stesso e di spostare anche il proprio lavoro di ricerca? Io credo di no e si possono fare anche numerosi esempi, esempi anche molto recenti aggiungendo, come considerazioni, dei punti fondamentali che la politica dovrebbe avere. Infatti la politica dovrebbe aggredire, e questo da parte di tutti i paesi in maniera concertata, i paradisi fiscali che costituiscono sempre più un grande forziere delle organizzazioni mafiose e che costituiscono un pericolo complessivo per l’economia e per il movimento mondiale dei mercati.
L’inserimento delle organizzazioni mafiose nei processi di privatizzazione va guardata con molto attenzione perché sono processi di una grande dimensione internazionale. Il riferimento va fatto al Centro - Est d’Europa per la sua nuova condizione economica e politica ma è pure vero che sono un altro punto di riferimento di un’altra azione internazionale, di un coordinamento internazionale necessario, nel senso che non possono essere considerati soltanto una grande area di transito o una rotta essenziale perché stanno diventando una sede d’investimento e di insediamento. Ci sono dei dati impressionanti forniti dall’Interpool a livello ONU sui sequestri di tonnellate di cocaina in Polonia, di eroina, di morfina base e di anidride ascetico, che è fondamentale per la produzione di eroina in Turchia. E ancora di sequestri nel confine tra la Bulgaria e la Jugoslavia, si è già accennato delle piantagioni in Albania, ci sono le anfetamine polacche e le droghe sintetiche soprattutto nei paesi dell’Est. Le anfetamine polacche sono quelle di migliore qualità nel mercato chimico della droga nel quale sono impegnati tutti i chimici che vengono espulsi dalle industrie in stato di crisi.
Ora noi abbiamo una situazione, cito anche il Montenegro, una situazione dove il rapporto tra le diverse organizzazioni mafiose e tra i diversi paesi è fortissimo e dove per un’azione antimafia internazionale che si contrapponga, bisogna fare riferimento a tre cose: 1) ad un possibile nuovo ruolo delle Nazioni Unite e anche dello strumento che le Nazioni Unite hanno a Vienna e dove adesso è stato incaricato del coordinamento l’On. Arlacchi; 2) c’è un nuovo impegno dell’Italia, una nuova cooperazione internazionale, il ruolo del nostro paese sia nel G7 che nell’Europa. I paesi del G7 hanno costituito recentemente un gruppo di lavoro, una commissione che lavora a stabilire dei nuovi punti di coordinamento. Da questi versanti io credo che si debbano muovere le cose per costruire uno spazio internazionale antimafia a partire innanzitutto da un circuito delle autorità di vigilanza bancaria e finanziaria dei vari paesi, perché solo questo può rispondere a quella istanza di riforma a quella azione di carattere preventivo che mi sembra di aver inteso da Napoleone Colajanni. Un circuito, e lo metto dopo e non prima, delle autorità di vigilanza bancaria e autorità delle Magistrature e delle polizie e la costituzione in rete tra loro di questi circuiti. 3) c’è da operare un monitoraggio comune delle legislazioni ed una armonizzazione tra le legislazioni andando ad una generalizzazione del 416 bis e di altri reati che oggi non c’è.
Alla generalizzazione degli strumenti come la D.I.A. nelle maggiori città e nei maggiori centri dell’unione europea e anche di altri paesi o dei paesi che dovrebbero dare vita a questo spazio internazionale antimafia. Di stabilire tra i Paesi che gli elementi di prova che si rapportano all’interno di uno Stato con le dovute garanzie, possono valere nell’altro Stato. E anche che in ogni Paese di questo spazio internazionale antimafia il reato commesso al fine di aiutare una organizzazione mafiosa anche all’estero in un altro paese possa essere perseguito. Di avere anche norme comuni sulla tutela dei testimoni, sui collaboratori, sulle difese dei mercati dei circuiti finanziari e della pubblica amministrazione da attacchi mafiosi. Nel senso che il campo degli appalti e dei subappalti, dei controlli sui versamenti bancari, di movimento della moneta elettronica e i rapporti con la pubblica amministrazione possano vedere una coerenza nella citazione dei vari Paesi. A questo appartiene anche il grande tema dell’aiuto ai soggetti della mafia e le sanzioni da parte di quelli che io dicevo il forziere, cioè i "paradisi fiscali". Sanzioni che siano legate ad una convenzione tra tutti i paesi che diano vita a questo spazio internazionale antimafia. Il tema dei sequestri e delle confische e lo cito non perché sia l’ultimo capitolo e il meno importante, ma solo per dire che oggi si rende necessaria una nuova legge "La Torre", un nuovo testo unificato di lotta sul terreno dell’economia nel senso delle riforme come qui è stato giustamente detto."
GIANNI PARISI: "Io non ho da concludere nel merito, solo voglio dire che il dibattito è stato molto interessante e probabilmente il tema di oggi meritava una giornata intera di dibattito, un organizzazione maggiore dei lavori, ma questo in futuro potrà essere ripreso.
Ringrazio tutti coloro che hanno parlato, i nostri relatori e il pubblico."
Il Presidente
Gianni Parisi
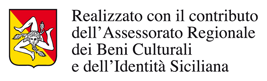
Chi siamo
Archivio
Contatti
Centro di Studi ed Iniziative Culturali
Pio La Torre Onlus
Via Umberto Boccioni, 206
90146 Palermo
Telefono/Fax +39 091 348 766
info@piolatorre.it
C.F. 93005220814